Girato muto del 1969 di manifestazioni e assemblee nelle università e nei licei e istituti tecnici di Roma (Mamiani), Milano (Parini), Bologna, Pavia e Palermo. A Roma, assemblea nel cortile dell'università. Studenti in motoretta aprono un corteo che sfila davanti al Colosseo


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Girato del 2012 a cura della Fondazione Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Le riprese riguardano la manifestazione nazionale della Cgil "Il lavoro prima di tutto!", indetta per chiedere al governo Monti di cambiare la sua agenda dando priorità alle scelte strategiche di politica industriale, alle misure di sostegno per i lavoratori e agli interventi per arginare la crisi che investe i lavoratori e per salvaguardare i precari.


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Girato muto a cura della casa di produzione Unitelefilm. Il 3 ottobre 1977 a Roma si svolge il funerale di Walter Rossi, un giovane di Lotta Continua ucciso dai fascisti la sera del 30 settembre in viale delle Medaglie d'Oro a poca distanza dalla sezione dell'Msi


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Girato muto anni settanta a cura della casa di produzione Bayerischer Rundfunk. Le operazioni di stampa, in una tipografia, della rivista Rinascita.


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Abstract: Breve documentario realizzato dal PCI nel 1949, a un anno dall'attentato a Togliatti, in cui si mostrano gli "Amici dell'Unità", i diffusori, all'opera in varie città italiane.
Il documentario si chiude con l'appello a sottoscrivere per il giornale.


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Girato muto a cura del Partito Comunista Italiano. Sonnino, (Latina), 1951. Contro la disoccupazione e l'inerzia del governo, gli operai attuano "uno sciopero a rovescio" costruendo una strada. Aldo Natoli, segretario della federazione provinciale del Pci, è presente insieme a tutta la popolazione


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Regia: Anna Lajolo, Alfredo Leonardi, Guido Lombardi, Paola Scarnati
Casa di produzione: Unitelefilm
Anno di produzione: 1970
Abstract: Il documentario illustra la lotta per la casa in una metropoli come la capitale d'Italia, dove il diritto di tutti ad avere un'abitazione civile trova ostacoli gravissimi nell'aumento caotico dell'urbanizzazione, nella speculazione edilizia, nella degradazione delle borgate, nell'estensione del fenomeno dei baraccati, che vivono in alloggi di fortuna e le cui condizioni di vita sono drammatiche da decenni. Partendo dalla situazione di Roma, il documentario affronta quindi il tema generale del problema della casa in tutto il paese, e quindi la lotta che le forze popolari conducono - anche attraverso nuove forme organizzative come le consulte popolari e i comitati di agitazione - sull'intero territorio nazionale per raggiungere l'obiettivo primo di una società civile: una casa degna di questo nome per tutti i cittadini. (AAMOD)

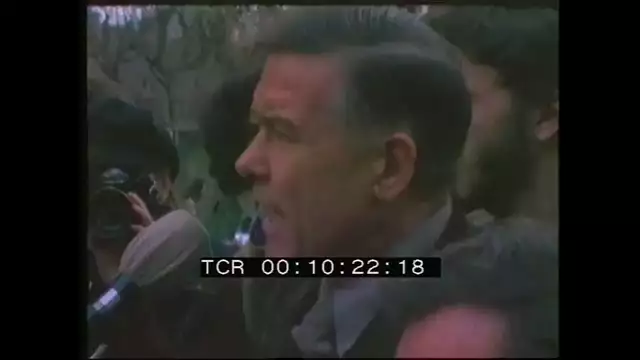
Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Regia: Ansano Giannarelli
Casa di produzione: Unitelefilm
Anno: 1979
Abstract: Una simbolica occupazione delle terre a Tivoli; una manifestazione per la scuola a Roma; un corteo di giovani disoccupati a Napoli; una manifestazione contro la violenza e il terrorismo a Genova: queste le situazioni - relative alla fine degli anni Settanta - documentate nel film. Al loro interno sono state raccolte interviste, dichiarazioni, testimonianze: ne emerge il ritratto di giovani studenti, operai, contadini, alle prese con problemi drammatici come quelli del lavoro, dell'occupazione, della ricerca di una casa, di nuovi modelli di vita individuali e sociali.
Gli esempi documentati sono emblematici della condizione giovanile alla fine degli anni settanta: dalla disoccupazione all'emigrazione, dall'impegno nelle cooperative agricole alle manifestazioni per una scuola rinnovata, dall'emarginazione alla protesta violenta e all'impegno politico attivo.


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Girato a cura della Fondazione AAMOD. La Fiom-Cgil ha organizzato, sabato 16 ottobre 2010, la protesta delle tute blu per dire sì ai diritti e no ai ricatti. A Roma, accanto ai metalmeccanici, anche i precari, gli studenti, i pensionati e gli immigrati. Poi gli uomini della politica e della cultura, le associazioni, i movimenti e l'università


Accedi per aggiungere questo video a una playlist. Accedi
Immagini mute girate da Pier Paolo Pasolini nel 1970, il documento è diviso in tre parti: la prima mostra le riprese dell'assemblea dei netturbini, la seconda mostra gli spazzini al lavoro ai Mercati generali di Roma, mentre l'ultima raccoglie le interviste ai netturbini sul loro posto di lavoro